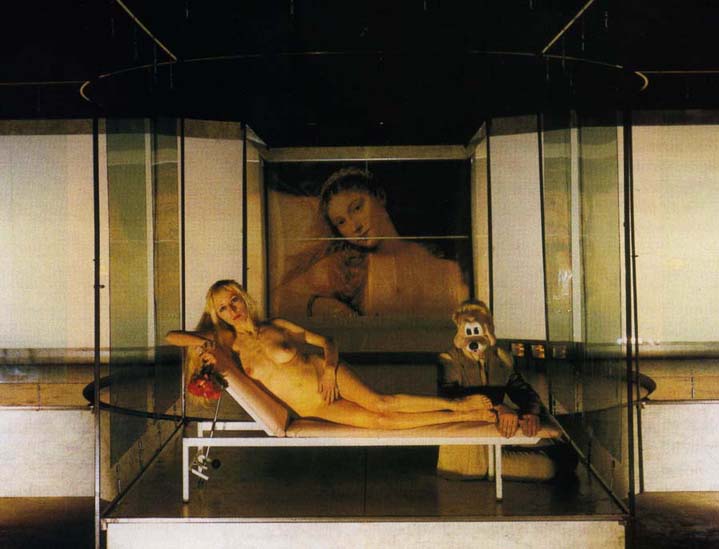
La melodia dello
sfondo
Intervista ai Motus (Daniela Niccolò ed Enrico
Casagrande)
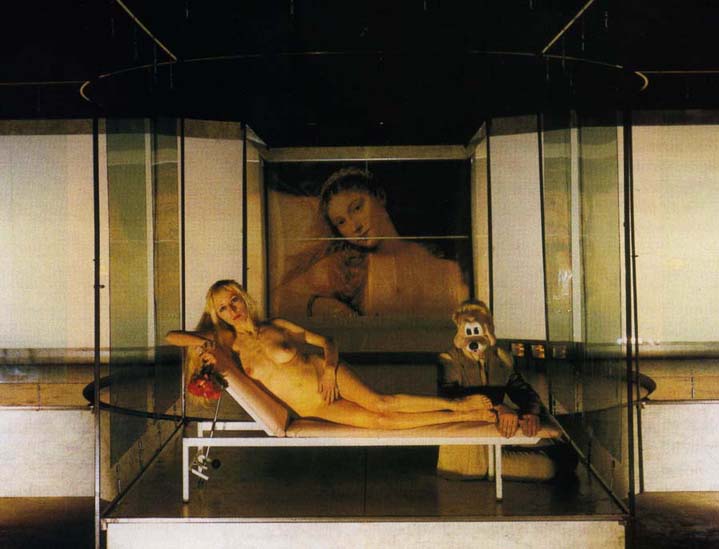
Vorrei partire dagli autori che avete affrontato
negli ultimi lavori, mi riferisco a Rilke e all’Ariosto: entrambi "di rottura"
per il periodo storico in cui vissero; critico della società borghese
di fine Ottocento il primo, e massimo esponente della Cultura della
Contraddizione rinascimentale il secondo. Io
affiancherei a Rilke e all’Ariosto anche Samuel Beckett che, come riferimento
dal punto di vista letterario, è quasi sempre costante nei nostri
spettacoli e, allo stesso tempo, James Ballard, che a suo modo è
un classico contemporaneo. Tutti questi autori hanno, come dici tu, una
forza dirompente e sono un briciolo più lungimiranti rispetto ai
loro tempi: riescono ad analizzare il periodo storico in cui vivono e allo
stesso tempo riescono a trasfigurarlo in letteratura, in poesia, con una
visione aperta, con uno sguardo oltre. Non riferendoci mai ai suoi scritti
poetici, siamo arrivati a Rilke partendo dal mito di Orfeo, dal desiderio
di lavorare su Orfeo. E i suoi Sonetti ad Orfeo ci hanno letteralmente
affascinato. Da qui è nata l’idea di porre una tappa intermedia,
dedicata e legata all’Essere Angelo. La caratteristica dei nostri
lavori è quella di cercare una commistione tra diversi elementi,
avendo però un lume di riferimento costante, che si può identificare
sia in un autore, sia in un tema artistico-letterario-filosofico. Leggendo
Rilke, ad esempio, il campo si è allargato a Benjamin, Holderlin,
Heidegger, Nietzsche.
Per quanto riguarda le contaminazioni che ci
possono essere tra arte, poesia e teatro, esiste uno scambio di ruoli tra
l’artista e l’attore? Penso ad esempio a The Solar Anus di Ron Athey
o alla vostra stessa scelta di creare un’installazione piuttosto che un
vero spettacolo. Il confine
è estremamente labile, non è più possibile tracciare
una demarcazione. È chiaro che il tempo di una performance è
diverso rispetto alla percezione di uno spettacolo teatrale, e in Éntrange
lo abbiamo voluto estremizzare: lasciare il pubblico libero di muoversi,
di spostarsi tra le diverse situazioni, prendendosi quindi un po’ più
di tempo. Partendo dalla stessa riflessione di Rilke sul tempo, sul vuoto,
sull’aperto, ci piaceva che rimanesse questo grande spazio popolato da
suoni come un interno sonoro. Ci interessava che la gente, oltre
che vedere, potesse sentire parole e sonorità varie, registrate
su mini-disc. Volevamo che questo frastuono si trasformasse in una melodia
dello sfondo: riuscire a dare una melodia a un suono che non è
di per sé melodico. In questo momento stiamo lavorando sulla commistione
tra la musica classica (dal Te Deum a Monteverdi, che fa parte della
direzione del nuovo lavoro, l’Orfeo) e il disturbo, l’interferenza
elettronica.
Secondo voi oggi c’è una prevalenza della
gestualità del corpo rispetto alla recitazione della parola? Credo
che ci sia una centralità del corpo; ma è anche vero che
non ci siamo mai posti come obiettivo il mettere in evidenza il corpo rispetto
alla parola. Quando andiamo a realizzare uno spettacolo, pensiamo a quello
che può essere il significante del lavoro che vogliamo realizzare.
E da qui partono delle emergenze, che possono riguardare anche la fisicità,
la corporeità. Noi crediamo in una nuova figura dell’attore: l’attore
non è più collocato o visto come un semplice portatore di sé in senso verbale ma, con tutta la propria presenza, l’esserci,
lo stare, dovrebbe riuscire a interpretare un punto nell’insieme dell’opera.
Riprendendo il discorso della melodia dello sfondo, tutte le cose
sono fondamentalmente parti di un tutto, in cui hanno la stessa valenza:
attori, corpi, parole, scenografia, suoni. Certo, in lavori come
Catrame c’è una prevalenza dell’azione fisica, che però
è continuamente interrotta, è continuamente violentata da
interventi esterni, anche vocali. In quel caso il movimento diventa partitura
del testo. Ma ogni spettacolo è indipendente dall’altro.
Quanto c’è di cinematografico nei vostri
spettacoli? A volte ho avuto l’impressione di penetrare voyeuristicamente
uno schermo, assistere ad un film tridimensionale. Il
punto di partenza del nostro lavoro è stato quello di voler tracciare,
tramite dei quadri, delle immagini o dei fotogrammi cinematografici, una
serie di segni che avessero la valenza del susseguirsi di enigmi. In Éntrange
è particolarmente vivo questo rapporto: essendo noi dietro dei
vetri a specchio, nel momento in cui ci facciamo vedere, lo spettatore
può osservarci; ma quando il vetro diventa specchio, siamo noi ad
osservare lui. E quindi emerge, da parte nostra, la visione dell’Essere
Angelo: essere effettivamente al di là di un essere vivente,
presente, e divenire trasparente, invisibile, una sorta di
angelo custode.
Forse è stata una delle azioni più divertenti perché
normalmente non puoi mai controllare il pubblico; in questo caso invece
ci rendevamo conto dei vari spostamenti, delle differenze tra i diversi
gruppi di pubblico durante la giornata: quello che si muoveva molto più
a gregge oppure l’anarchico assoluto che ti si piazzava davanti anche al
buio cercando una continua relazione. È interessante come Rilke,
nella seconda elegia, descriva questi angeli che, come loro visione, hanno
degli specchi ("Voi, primi perfetti, viziati dalla Creazione, […] e a un
tratto, uno per uno, specchi: la bellezza che da voi defluisce la
riattingete nei vostri volti"). Sono in un certo senso autogenerati da
se stessi: lo specchio diventa la presenza dell’angelo in sé. L’immagine
dello specchio rimanda anche all’Orfeo cinematografico di Cocteau:
nel film il passaggio dall’altra parte è rappresentato dallo specchio
di un armadio, e l’angelo è un vetraio. Tra l’altro ho scoperto
che Rilke poco prima di morire voleva tradurre proprio l’Orfeo di
Cocteau.
E quindi avviene la rottura totale dello spazio
teatrale classico: senza giungere ai casi estremi della Fura dels Baus,
si compie un’interazione tra attori e pubblico. Sì,
anche se noi non siamo mai così invasivi, così violenti.
Questa interazione esiste, ma è sempre mediata dal fatto che ci
poniamo distanti, sottoplexiglas o sottovetro, mentre la Fura entra, rompe,
crea una fusione istantanea. La presenza di un filtro è stato un
elemento importante. In Catrame è presente soprattutto il
discorso cinematografico a cui accennavi prima. Tutto è nato da
un forte riferimento a Ballard (La mostra delle atrocità),
a Bacon e allo studio del movimento; abbiamo ricreato un grande schermo,
suddiviso in porzioni di spazio segnati da numeri, in relazione proprio
allo scorrere di un trancio di pellicola, singoli fotogrammi che si rincorrono.
C’è una ricerca sulla bidimensionalità, a differenza di O.F.
dove abbiamo mantenuto una struttura che acquisisse una profondità:
lo spazio a forma di croce, legato ai cavalieri, come visione prospettica,
dà la possibilità di avere più livelli di visione
e di lettura.
Limitandone la fruibilità a un numero
ridotto di spettatori, non si rischia che gli spettacoli assumano la connotazione
di riti ristretti a pochi adepti? Noi
in realtà siamo molto contrari a questo: nel caso di Éntrange
è stata una scelta legata a esigenze tecniche. Anzi ci è
dispiaciuto molto perché in genere amiamo avere una confronto con
la massa, gli spettacoli di massa danno un vissuto in sé molto più
collettivo e catartico. Probabilmente è interessante il rapporto
che sorge dall’essere in pochi spettatori e quindi questo aspetto rituale,
ma sinceramente non ci appartiene. Proprio per questo abbiamo voluto evitare
ogni dimensione itinerante, abbiamo preferito lasciare il pubblico libero.
Per Éntrange
avremmo preferito, piuttosto che suddividere
il lavoro in mezzore, lavorare per due ore continue in cui tu potevi arrivare,
entrare, stare un quarto d’ora/dieci minuti, uscire, proprio come avviene
in una galleria d’arte.
Prima di raggiungere il riconoscimento attuale,
qual è stata l’evoluzione percorsa da voi e dalle altre compagnie
dell’ultima ondata? Posso parlare della situazione dell’Emilia
Romagna, che è quella che conosco meglio. Effettivamente è
un fenomeno particolare: tutte noi, da Fanny a Clandestino, abbiamo iniziato
più o meno nello stesso periodo in condizioni economiche e culturali
veramente disastrose: autoproducendoci gli spettacoli, non avendo un circuito,
inventandoci delle piccole rassegne in luoghi sperduti della Romagna. E
siamo stati in un certo senso i pubblici reciproci, perché inizialmente
non c’era ancora questo tipo di eco. Queste ristrettezze economiche ci
hanno spinto a specializzarci un po’ in tutti i settori: dallo scenografo
al fonico, ecc. Si è sempre più approfondito questo sapere
comune, anche tramite scambi di mezzi… Pietro dei Clandestino faceva il
tecnico per noi, abbiamo organizzato festival insieme, c’è stato
proprio uno scambio di competenze. È chiaro che vedendo reciprocamente
gli spettacoli ci sono state delle suggestioni reciproche. Ma, a livello
drammaturgico, si sono prese strade veramente diverse… anche se si è
mantenuta una similitudine a livello di modi di produzione, di utilizzo
di certe tecnologie. Tutti quanti stiamo lavorando progressivamente con
il computer per quello che riguarda il suono (ci siamo passati gli stessi
software…!), ma a livello stilistico continua ad esserci una differenza
di immaginario, di riferimento. Poi penso che le produzioni dell’Emilia
Romagna siano molto diverse rispetto a quelle delle altre regioni, non
per fare un discorso di priorità o meno: ci sono altri mondi, riferimenti
diversi. In Romagna, col festival di Sant’Arcangelo, con Ravenna
Teatro, con la presenza di compagnie storiche, abbiamo avuto la possibilità
di vedere cose più particolari che in molte regioni non arrivano
neanche. In realtà è sempre stata forte da parte nostra e
anche da parte degli altri il desiderio di trovare un proprio linguaggio:
continuamente si tende a rimandare la paternità delle nostre esperienze
alla Raffaello Sanzio o alla Valdoca. È chiaro sono realtà
importantissime e hanno aperto delle porte; sono state un esempio soprattutto
per quanto riguarda il modo di lavorare: questa dedizione totale, questo
impegno di studio e ricerca. Però noi cerchiamo di trovare una nostra
propria identità.
Ma oggi i famosi finanziamenti statali sono arrivati
o no? A noi non sono ancora arrivati! Abbiamo fatto domanda
ministeriale, ci siamo messi in regola con l’ENPALS, poi al momento dello
stanziamento è subentrato il problema del territorio: non potevano
concentrare troppi fondi in Emilia-Romagna e così ci hanno lasciato
fuori. Per noi è un grosso handicap perché, a parte i costi
delle tecnologie e dei materiali, ci permetterebbero di crescere professionalmente,
ci darebbero veramente la possibilità di essere dei lavoratori dello
spettacolo, e non dei lavoratori in nero. Inoltre rafforzerebbero la nostra
struttura che oggi si regge sul nulla: rapporti interpersonali di grande
fiducia, di grande dedizione, ma di forte sacrificio economico. Ci sarebbe
piaciuto poter invece, avendone le capacità, trasformarci in un qualcosa
di più stabile. Anche perché continui ad essere guardato
e valutato dalla critica alla stregua delle produzioni teatrali delle grandi
compagnie… In realtà le condizioni di realizzazione ed elaborazione
sono diversissime: una mole di impegno, di lavoro e di rischio non pagato
e non riconosciuto dall’occhio esterno. Quest’anno siamo stati segnalati
come finalisti per il Premio Ubu quale migliore scenografia. Però
una nostra scenografia, senza nulla togliere, è veramente sudata…
fatta da noi con i nostri mezzi e, per quanto bellissime possano essere,
sapendo quali finanziamenti ci sono dietro le altre, ti scontri veramente
contro un handicap, un limite. Già è un lavoro così
difficile da poter crederci fino in fondo, perché rimane sempre
volatile, in più se non sei nemmeno riconosciuto o non hai un supporto
per poterlo fare con tranquillità… speriamo per il prossimo anno.
interview by federico mataloni.